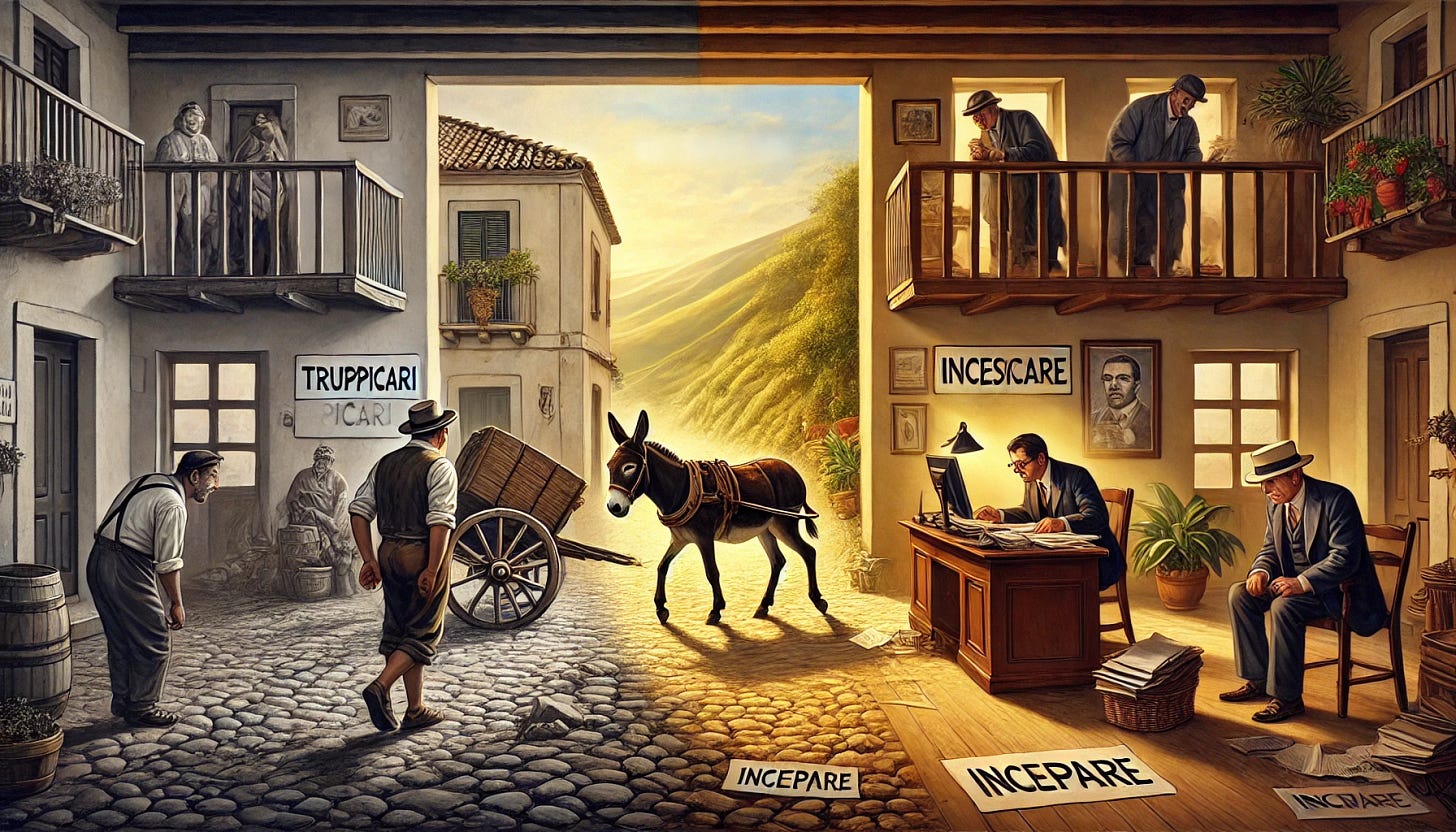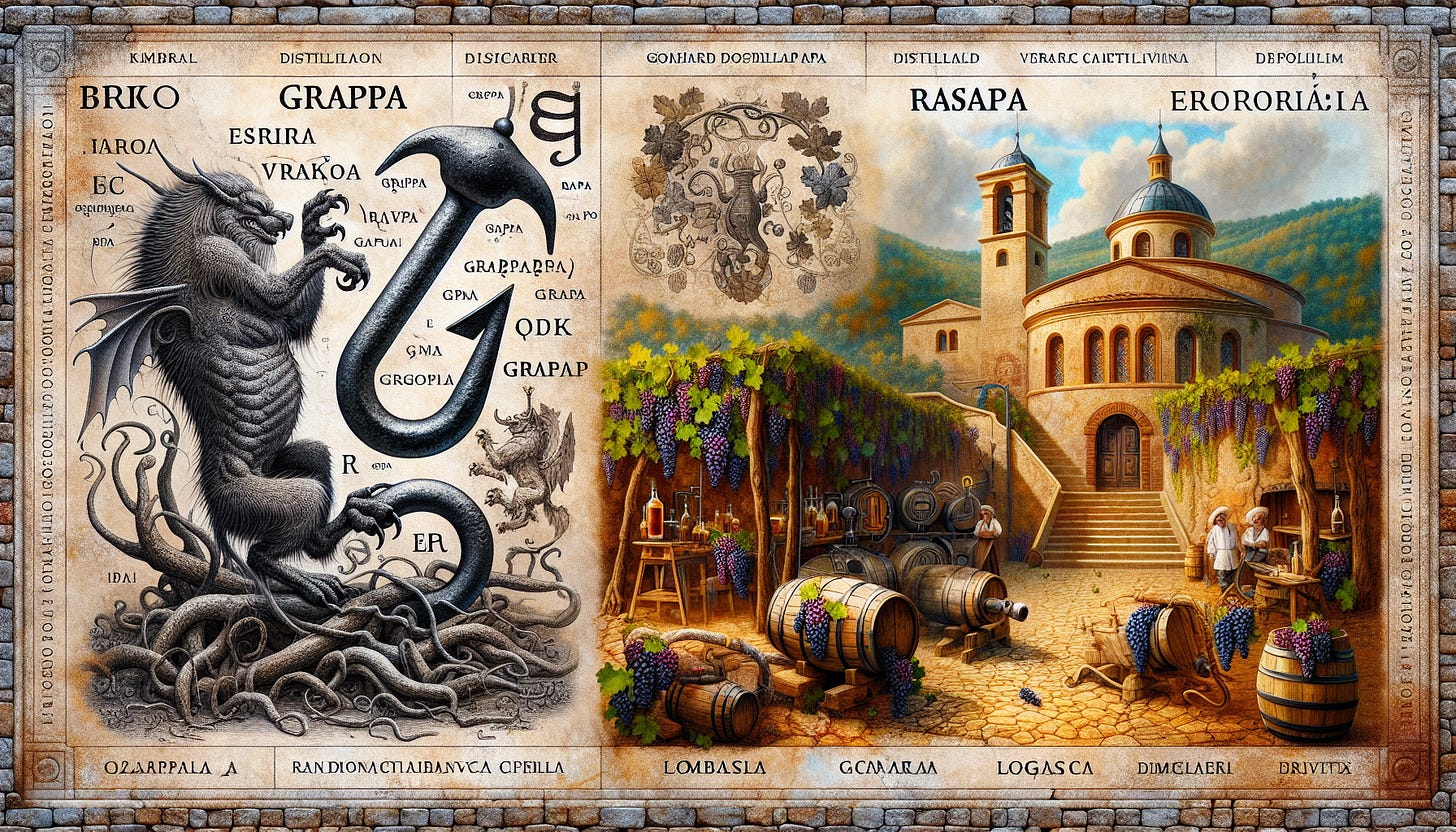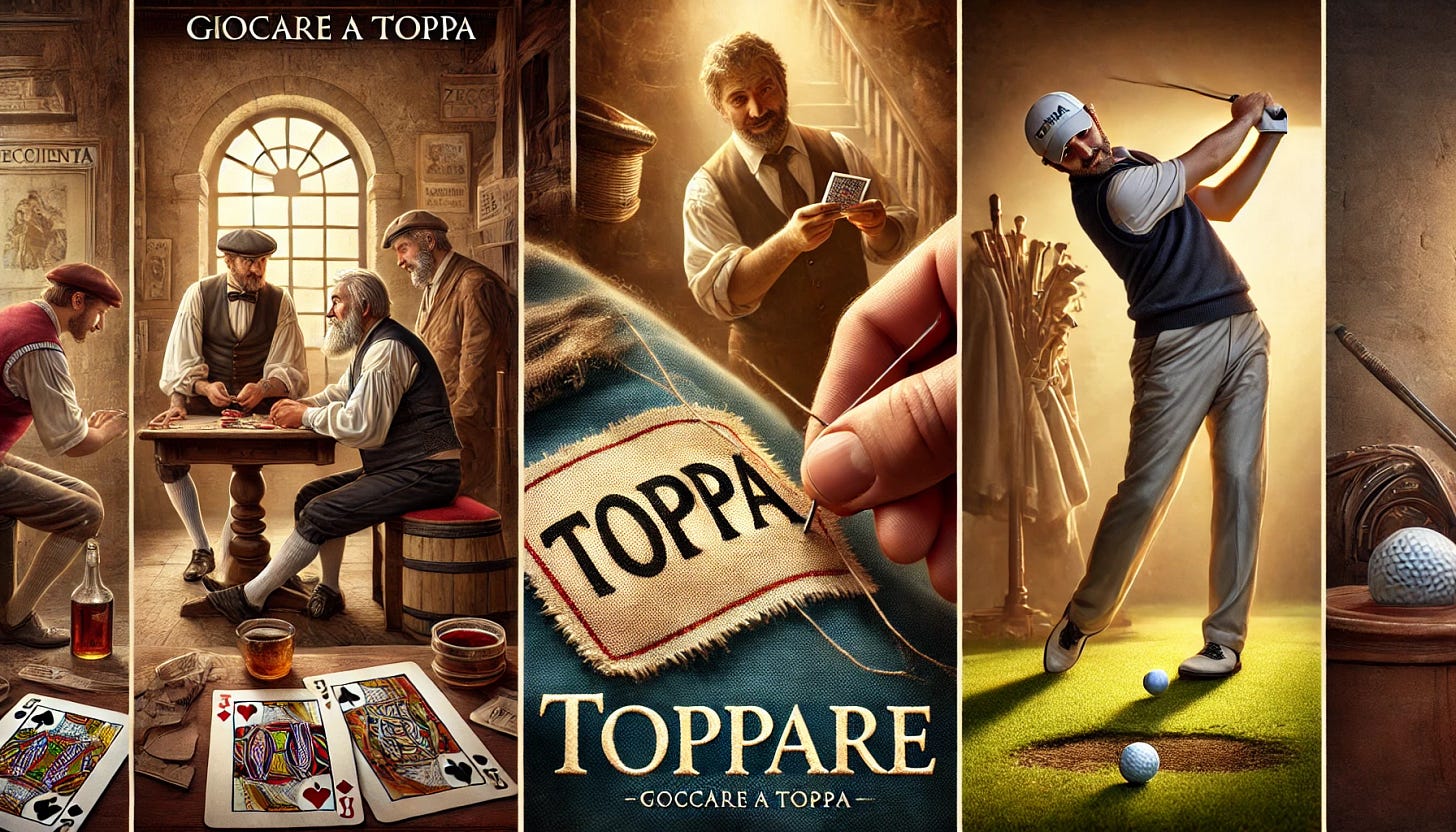Il sostantivo greco tópos indicava il posto, il luogo, quello che per i Romani era il locum. Ma il latino aveva anche altri termini che la nostra lingua ha ereditato per indicare il luogo: da situm, participio passato del verbo sinere, con il significato di posare, lasciare, sono venuti il nostro sito ed il verbo latino medievale situare, che ha generato il corrispondente verbo italiano. Ma non basta, in quanto i Romani avevano anche il verbo ponere, tratto dallo stesso sinere con il prefisso po-, forma arcaica di apo-, rappresentato normalmente in latino da ab-. Questo il percorso, secondo Giacomo Devoto: posinere, posnere e finalmente ponere, con il significato di mettere giù, collocare, porre. Dice il Devoto: “mentre sinere non si preoccupa della sorte della cosa lasciata, ponere la considera collocata definitivamente”, per cui rispetto al primo esprime un’azione conclusa (Avviamento alla etimologia italiana, Mondadori Scuola 1995).
E dal participio passato di ponere, ovvero positum, giungiamo alla fine al nostro posto ed alla sua numerosa figliolanza, tra cui, per farla breve, posta, postino e, per chi ha la fortuna di trovarlo, posteggio. Perché posta? Quando per il trasporto celere di persone e cose si dovevano coprire lunghe percorrenze con il solo mezzo veloce disponibile, ovvero il cavallo e le carrozze da questo trainate, lungo il percorso era necessario procedere al cambio dei cavalli e spesso anche del cavaliere: ciò avveniva alla ‘posta’, dal latino ‘posita’ ovvero ‘i (luoghi) stabiliti’ per la fermata ed il cambio, dove in genere si trovavano anche piccoli alberghi. Dal XVII secolo questo servizio fu utilizzato anche per trasportare quella che già dal XVI secolo si chiama corrispondenza (epistolare) e così posta, luogo stabilito per il cambio, ha finito per dare il nome anche alla posta intesa come servizio per la spedizione e il recapito di lettere e cose varie. Epistolare viene dal tardo latino epistolarem da epistola, lettera, a sua volta dal greco epistole, lettera, missiva, derivante dal verbo epistello, inviare, spedire.
Ancora due parole sul termine sito. Pirandello nella novella La Verità del 1912 racconta la storia del contadino Tararà, accusato di aver ucciso la moglie adultera. La novella inizia con l’introduzione di Tararà nella gabbia della Corte d’Assise: assistevano al processo anche i contadini della zona, che Prandello descrive così:
“Dalla folla di tutti quei contadini si levava denso, ammorbante, un sito di stalla e di sudore, un lezzo caprino, un tanfo di bestie inzafardate, che accorava.”
Ebbene qui sito non significa luogo ma cattivo odore, tanfo, sempre dal latino situm che oltre a sito, posto significava anche putredine, muffa come effetto di lunga mancanza di cura, di abbandono, ad esempio di un magazzino dismesso.
E Tararà? Nonostante l’avvocato cerchi di fermarlo, l’ingenuo contadino confessa di aver ucciso la moglie non per il tradimento in sé, ma a causa dello scandalo causato dalla moglie del cavalier don Agatino Fiorica, colto in fragrante adulterio (in maniche di camicia e coi calzoni in mano) con la moglie dell’imputato: così, dice Tararà, questa signora ha reso pubblico quello che sarebbe dovuto rimanere confinato nelle mura domestiche, per cui non potevo perdere la faccia davanti ai concittadini rimanendo senza far niente. E in grazia della verità, così candidamente confessata, Tararà fu condannato a tredici anni di reclusione. Ma la novella va letta tutta, con vero piacere.
Tornando a topos scopriamo che l’aggettivo derivato átopos, per la presenza dell’alfa primativa, significava fuori posto e, quindi, insolito, strano, da cui il sostantivo atopía con il significato di stranezza, singolarità, condotta non naturale: quest’ultimo termine nella nostra lingua è stato preso in prestito dalla medicina, la quale con atopia indica la predisposizione ereditaria ad alcune manifestazioni morbose, quali la pollinosi ed alcune forme di asma bronchiale e di orticaria, rientranti nell’ambito dell’allergia, caratterizzate da manifestazioni bizzarre e non usuali. In poche parole, niente da stare allegri.
La lingua italiana utilizza anche l’aggettivo atopico, il quale, oltre a significare relativo all’atopia, indica un fatto patologico non classificabile in modo definito, come, ad esempio, un eczema atopico e viene, altresì, usato come sinonimo di ectopico, dal greco éctopos, composto di ek, al di fuori di, e tópos, che, come abbiamo visto significa posto. Si dice ectopico un organo situato in sede diversa da quella naturale. Ectopia è, infatti, l’anomalia di posizione di un organo: si ha, ad esempio, ectopia testicolare quando uno o ambedue i testicoli rimangono al di sopra o all’interno del canale inguinale, per cui non si trovano nello scroto, loro sede naturale; od ancora si ha il situs inversus viscerum, quando il cuore o la milza sono a destra ed il fegato a sinistra. Ectopia indica una anomalia congenita; quando, invece, si ha uno spostamento della sede abituale di cellule o di un organo (ad esempio, un rene) si parla di migrazione, latino migrationem, dal verbo migrare, andar via, trasferirsi altrove, da cui il composto emigrare (ex e migrare), cambiar sede che ha originato il nostro emigrare.
Il termine greco tópos è diventato nella nostra lingua primo o secondo elemento per la formazione di molte altre parole scientifiche o, comunque, dotte, apportando il significato di ‘luogo’, come ad esempio:
con philía, amore, topofilia (profondo amore per un luogo)
con phobía, paura, topofobia (forte paura per un luogo)
con graphía, scrittura, topografia (rappresentazione grafica di un terreno)
con bíos, vita, biotopo (unità dell’ambiente fisico, come un bosco o un lago, caratterizzato da condizioni relativamente uniformi)
con ónyma, variante di ónoma, nome, toponimo (nome di un luogo)
con ísos, uguale, isotopo (detto di elementi il cui nucleo, pur avendo un numero diverso di neutroni e quindi una differente massa, presenta però un ugual numero di protoni e quindi una uguale carica elettrica ed un ugual numero di elettroni esterni). Il termine isotopi deriva dal fatto che gli elementi di cui sopra occupano il medesimo posto nel sistema periodico degli elementi o classificazione di Mendeleev (Dimitrij Ianovic, 1834-1907), chimico russo che per primo enunciò scientificamente la legge secondo cui le proprietà fisiche e chimiche degli elementi sono funzione periodica del loro peso atomico
con ou, non, utopia (progetto, aspirazione irrealizzabile). Dal titolo dell’opera, in prosa latina, De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia, pubblicata nel 1516 dal filosofo inglese Thomas More (1478-1535), italianizzato in Tommaso Moro, il quale, volendo fustigare le gravi colpe della società del suo tempo, creò uno stato immaginario nella fantastica isola di Utopia (che non si trova in nessun posto), nella quale vengono attuati ideali sistemi di vita comunitaria: obbligatorietà del lavoro, ma con il limite di sei ore giornaliere perché l’operaio possa coltivare anche la mente, limitazione del numero degli intellettuali considerati improduttivi, soppressione della proprietà privata, pasti frugali, rifiuto della guerra (non vi è cosa più biasimevole della gloria acquistata con la guerra),….
Il greco Tópos ha generato anche il termine topica, la quale, nella retorica classica, è la teoria e la ricerca dei luoghi comuni ovvero degli argomenti a cui si può far ricorso in una dimostrazione. Ed il relativo aggettivo topico, oltre a significare ‘che riguarda la topica’, per cui si parla di scritti topici e, con evidente tautologia, di luogo topico, viene usato anche nel senso di ‘che si riferisce ad un luogo’, mentre in medicina indica un farmaco da applicare esternamente su una parte delimitata del corpo, come una pomata o un impacco.
Ma allora perché si dice ‘fare o prendere una topica’ nel senso di sbagliare, fare una mossa inopportuna? Questa, in effetti, è tutta un’altra storia che nasce in Lombardia, dove per dire inciampare usano il verbo ‘(in)topicà’, il quale, come l’italiano intoppare, dovrebbe originare da in e toppo. Infatti, essendo il toppo la base del tronco di un albero che rimane nel terreno dopo il taglio del fusto è un ottimo ostacolo su cui inciampare al pari di un sasso. Dicono i Lombardi: L’hà topicaa in d’on sàss e l’è borlaa giò (inciampò in un sasso e cadde). Toppo deriva dall’antico francese top, a sua volta dal francone top, punta, cima, che alle signore ha regalato il toupet e agli inglesi il top dai vari significati (cima, vetta, capo, tettuccio di automobile, parte superiore di abito femminile…), esportato anche in Italia, e non solo, ad esempio nel campo della moda. Da intoppare, oltre ad intoppo, ostacolo, impedimento, potrebbero venire il romanesco ‘intruppà’, urtare, cozzare, e l’italiano intruppare ambedue con epèntesi di ‘r’. Per chi non lo sapesse, epèntesi, dal greco epénthesis, inserzione, è l’inserimento di una vocale o di una consonante non etimologiche all’interno di una parola cosicché la pronuncia ne risulti facilitata: così, ad esempio, il latino viduum (spogliato, privato, vedovo) in italiano è diventato ‘vedovo’ con epèntesi della ‘v’.
Quando intruppare indica riunire in una truppa, la sua derivazione è, appunto, da truppa col prefisso -in: truppa ha il suo riscontro immediato nel francese troupe a sua volta dal termine troupeau, gregge, branco, dal francone throp, agglomerato di persone.
I Siciliani, a loro volta, usano il verbo truppicari, come nel proverbio “Trùppica un sceccu [asino] cu quattro pedi e nun avi a càdiri chiddu cu dui?”. Sempre meno si usa intoppare nel senso di incontrare inaspettatamente o improvvisamente una persona antipatica o un creditore o un ostacolo che blocca chi, magari, non è nel pieno delle sue capacità, come nel vecchio proverbio “Si va capra zoppa, se ‘l lupo non la ‘ntoppa”. Sempre pronto a verificarsi il derivato intoppo, nel senso di contrattempo, intralcio ad esempio nello svolgimento di un lavoro o di una pratica burocratica, termine quest’ultimo che ci hanno regalato i Francesi con bureaucratique da bureaucratie, composto da bureau, ufficio e -cratie, potere.
Analogamente ad intoppare, si sono formati altri verbi, come incespicare, inceppare e inciampare. Incespicare significa urtare con il piede contro un ostacolo ed anche parlare senza speditezza e viene da ‘in’ e ‘cespicare o cespitare’, verbi ormai non più in uso derivanti da cespite (latino caespitem) con il significato di zolla erbosa ma anche di cespo (latino volgare cespum) o gambo da cui nascono molti getti e, quindi, figurativamente capitale produttivo, fonte di reddito; e da cespo abbiamo cespuglio, insieme di rami e foglie che provengono da una sola radice.
Inceppare viene da in e ceppo (latino cippum) che è la parte inferiore di una pianta dalla quale si dipartono sia le radici sia il tronco, per cui indica anche il capostipite di una famiglia. Facciamo una piccola digressione: in latino Scipio, Scipionis era il cognome della gens Cornelia, come dire gente tipo Scipione Africano, vincitore di Annibale a Zama, o Scipione Asiatico, vincitore di Antioco III, o, ancora, di Scipione Africano minore, distruttore di Cartagine e Numanzia. Ma scipio-onis era anche uno dei termini con cui i Latini indicavano il bastone e, secondo il Dizionario Etimologico del Nocentini, il latino cippus è probabilmente una variante popolare di scipio-onis con abbreviamento della vocale e allungamento della consonante.
Oltre alla porzione di grosso tronco che si brucia nel caminetto, viene chiamato ceppo anche il grosso blocco di legno su cui si decapitavano i condannati a morte e ceppi gli arnesi di legno nei quali si costringevano i carcerati, per cui inceppare ha assunto il significato sia di imprigionare (mettere in ceppi) sia di ostacolare, bloccare non solo il movimento di qualcosa ma anche la lingua di qualcuno, come potrebbe accadere bevendo troppo alcool. Ed ancora, figuratamente, ceppo si usa per indicare un gruppo di batteri e virus con caratteri simili (ceppo batterico o virale) o, ancora, un gruppo di lingue con comune origine (ceppo linguistico). Ed altri usi ancora come il ceppo dell’ancora o dell’aratro, quello per sostenere l’incudine o per tagliare la carne.
Inciampare viene da in e ciampa, variante di zampa, ed ha significati analoghi ad intoppare, ovvero urtare con il piede ed imbattersi all’improvviso in qualcuno. Zampa è probabilmente un incrocio tra gampa (poi gamba) e zanca. Gamba è dal tardo latino gambam, che inizialmente indica il garretto del cavallo venendo dal greco Kampé, curva, articolazione di membro, da una radice indoeuropea kap o kam, e successivamente utilizzato anche per l’uomo. Zanca, in disuso per gamba, indica oggi il gancio di ferro che collega parti in muratura, detto anche grappa, e viene dal tardo latino zancam, specie di calzatura in pelle morbida presso i Parti, da un termine greco bizantino.
Grappa, come gancio di ferro, viene dal gotico krappa, uncino, da cui anche graffa. Grappa, come acquavite, secondo alcuni viene dallo stesso gotico krappa attraverso una forma dialettale lombarda, secondo altri, invece, viene si dal lombardo grapa, ma come derivazione di grapo, raspo, il grappolo d’uva privato dei chicchi, residuo della pigiatura, usato nel processo di distillazione. È il termine germanico occidentale hraspon, grattare, che ha generato il verbo raspare, levigare con la raspa, il quale, a sua volta, avendo riguardo allo strumento per grattare ha partorito la raspa, mentre avendo riguardo all’esito del grattare ha partorito il raspo di cui sopra. I più anziani ricorderanno che la raspa era un ballo d’origine messicana, simile alla samba, in voga, intorno agli anni cinquanta del novecento, sia in America sia in Europa.
Poco chiari i rapporti tra intoppare e toppare, il quale come termine arcaico significa giocare a toppa, ovvero ad un gioco d’azzardo a carte simile alla zecchinetta, mentre come termine familiare si usa nel senso di sbagliare. Quanto a toppa, oltre al gioco già detto, indica, sembra come femminile di toppo, spuntone d’albero, e, quindi, come cosa che chiude o ostruisce, sia la serratura o il buco della stessa sia il pezzo di vario materiale che si applica su un punto rotto di qualcosa (le tasche a toppa essendo sovrapposte sono simili ad una toppa). Quanto, invece, a toppare nel senso di sbagliare, secondo il Dizionario Italiano Ragionato, Firenze 1988, deriverebbe dall’inglese top, parte superiore, in quanto in alcuni sport, come il golf, il verbo indicherebbe il fatto di colpire malamente la palla nella parte superiore, imprimendole una traiettoria sbagliata. Il Nocentini, invece, ritiene toppare un derivato di toppa nel significato gergale di figuraccia.